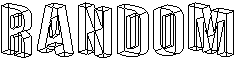I nuovi amatori: citizen artists o scimmie infinite?
“The interactive aesthetic experience with computers might fill a substantial portion of that great leisure time predicted for the man of the future.” (Michael A. Noll, 1967)
Sono passati più di quarant’anni da quando Michael A. Noll, allora ingegnere presso i famigerati Bell Laboratories, firmava “The Digital Computer as a Creative Medium”, saggio seminale che rappresenta ancora oggi una delle riflessioni più lucide e al contempo visionarie sulle possibilità estetiche, allora appena nascenti, degli elaboratori. In quegli anni i computer erano macchinari enormi e complicati, accessibili solo a una ristretta comunità di scienziati e ingegneri. Furono questi ultimi, non a caso, a dar vita ai primi, pionieristici tentativi di indagarne le potenzialità creative e artistiche, sia a livello teorico che attuativo. Il personal computer come oggetto abituale e onnipresente – talmente consueto da diventare invisibile – e l’infiltrazione massiccia delle tecnologie digitali in ogni ambito della vita professionale e quotidiana erano scenari difficili da immaginare. Ancora più remota era la visione di un mondo dominato dalle logiche di Rete, scandito da connessioni sempre attive, animato da tentacolari social network e brulicante di produzione di conoscenza sotto forma di codice binario. Nonostante ciò, le poche premesse di cui Noll disponeva per la sua riflessione lo condussero non solo a individuare precocemente il nodo gordiano delle relazioni tra creatività e programmazione (il rapporto tra caso e controllo; il potenziale generativo delle dinamiche randomiche; l’interazione uomo-macchina come fulcro dei nuovi processi artistici), ma anche a mettere a fuoco un risvolto della questione rimasto poi sottotraccia per decenni e ora esploso in tutta la sua deflagrante forza problematica.
Nel paragrafo “Artistic consequences”, in modo se vogliamo accennato rispetto al cuore dell’indagine, ma nondimeno chiaro, Noll si sforza di ipotizzare le possibili ricadute di un uso massiccio e democraticamente diffuso delle tecnologie digitali: l’esperienza estetica mediata da computer sarebbe divenuta “altamente individualistica”. Secondo l’autore, infatti, un’accresciuta accessibilità ai mezzi di produzione creativa, insieme a una loro sempre maggiore facilità di utilizzo, avrebbe liberato gli autori dalla necessità di acquisire una solida competenza tecnica nell’uso dei differenti media, e in alternativa, aggiungeremmo noi, di avvalersi del lavoro di un’equipe con attitudini interdisciplinari (pratica invece molto comune nei rari esempi di arte digitale degli Anni Sessanta e Settanta).
Se da una parte l’avverarsi di una simile previsione era quasi scontato – basti pensare al simile effetto provocato nel mondo dell’arte dall’invenzione della fotografia o dall’introduzione di videocamere portatili e videoregistratori – nel caso delle tecnologie digitali l’impatto di un tale processo ha avuto e sta ancora avendo conseguenze di gran lunga più profonde, che non si fermano nel ristretto, seppur importante, ambito della pratica artistica. Innescando un dibattito che non è più soltanto gingillo teorico per il critico d’arte o lo studioso di estetica, ma che arriva a mettere in discussione l’intero sistema di produzione e distribuzione della conoscenza umana.
È ancora una volta Noll, nello stesso saggio, a gettare il seme, quando scrive: “Di questo genere di partecipazione nell’esperienza creativa ed estetica può fare esperienza sia l’artista che il non-artista [!] Plausibilmente, potrebbe emergere una forma di ‘citizen artist’ [!]. L’esperienza estetica interattiva con i computer potrebbe costituire una porzione sostanziale dell’ampia quantità di tempo libero che immaginiamo per l’uomo del futuro”.
La stessa espressione “citizen artist” – che Noll prende a prestito da un articolo firmato dallo storico Allon Schoener nel 1966, pubblicato sulla rivista “Art in America” – ci riporta, come un link immediato, al dibattito attuale sulla cosiddetta “cultura amatoriale” (pensiamo ad esempio al fenomeno crescente del “citizen journalism”, che vede la partecipazione di lettori e reporter non professionisti al sistema dell’informazione). Non solo oggi i mezzi di produzione sono più che mai accessibili in tutti i campi (arte, musica, cinema, letteratura, giornalismo), ma grazie alla flessibilità del linguaggio digitale e alle reti, anche il volto della distribuzione è cambiato per sempre. La cultura amatoriale infatti, è sempre esistita, ma mai prima d’ora il non-professionista ha avuto accesso a sistemi di distribuzione efficienti e di scala mondiale. E mai prima d’ora l’interconnessione globale ha permesso lo scambio immediato e continuo delle conoscenze. L’Amatore del Ventunesimo Secolo raggiunge spesso livelli di competenza difficilmente immaginabili prima, perché anche la formazione è continua e accessibile (attraverso l’e-learning, la vitalità delle comunità virtuali, i progetti di ricerca e creazione collaborativa).
Alla riflessione sulle potenzialità tecnologiche dobbiamo poi intrecciarne una di taglio più squisitamente culturale. L’invadenza e la tendenza omologante dei mezzi di comunicazione (includendo in questa definizione approssimativa non solo l’informazione ma tutta la cultura di massa, compresi l’intrattenimento e l’advertising) ha raggiunto negli ultimi vent’anni un livello di saturazione, generando comprensibili e legittimi fenomeni di intolleranza, diffidenza e finanche rifiuto. Il diffondersi di voci “alternative”, di pratiche capaci di muoversi al di fuori della corrente livellante del mainstream, di prodotti culturali frutto di una genuina passione creativa, è stato accolto con sollievo, incoraggiato e persino – talvolta acriticamente – celebrato.
Il panorama che si delinea all’orizzonte oggi, mentre ancora ci sforziamo di prendere coscienza del nuovo status, è magmatico: pieno di energie ma, come accade in tutte le mutazioni, non privo di risvolti dolorosi e controversi. Charles Leadbeater, sostenitore dei processi collaborativi e autore nel 2008 di “We-think. Mass Innovation, not mass production” dava il via al dibattito, proseguito poi a colpi di articoli, post su blog e saggi, nel 2004, firmando con Paul Miller (fondatore del social network dedicato alla formazione “School of Everything”) “The Pro-Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and society”. In questo pamphlet di settanta pagine – disponibile anche online in pdf – i due autori testimoniano della potenza del nuovo scenario e coniano una definizione per questa nuova figura di “amatore con standard da professionista”: il Pro-Am, appunto. Si tratta di una descrizione accurata e convincente del fenomeno, sostenuta da un riconoscibile piglio ottimistico, dall’aspirazione verso una condivisione sempre più ampia della conoscenza, dalla fiducia nelle potenzialità dell’”intelligenza collettiva” che, teorizzata una quindicina di anni fa da Pierre Lévy, inizia solo da qualche anno a rendersi disponibile all’osservazione nelle sue applicazioni pratiche. In fondo, si tratta di una posizione simile a quella presa da Gene Youngblood nel 1982, quando nel catalogo dell’edizione annuale di Siggraph, Mecca internazionale degli appassionati di Computer Graphic, scriveva: “Nessuna motivazione è più pura, nessun risultato più pieno di dignità di quello dell’amatore che lo fa per amore. [!] Uno strumento è ‘maturo’ tanto più è facile da usare, accessibile a chiunque, capace di offrire alta qualità a basso costo, e caratterizzato da una pratica pluralistica anziché singolare, utile per una moltitudine di valori. Il professionalismo è un modello arcaico che sta svanendo nel crepuscolo dell’Era Industriale!” .
Particolarmente utile per comprendere lo scenario, soprattutto dal punto di vista dell’influenza che queste pratiche “amatoriali” stanno avendo sull’assetto dell’industria dei media, è la ricerca di Henry Jenkins, che in saggi come “Cultura Convergente”, e ancora di più in “Fan, Bloggers and Videogamers”, offre un viaggio nei meandri delle odierne culture partecipative, mostrando come il sistema mainstream venga costretto, giorno dopo giorno, a prendere coscienza di queste nuove forze culturali che emergono “dal basso” e metta in pratica, con successi altalenanti, forme di apertura e di “inglobamento” strategico. Si tratta, com’è facile intuire, non solo di strategie di difesa tese a ribadire una secolare autorità e un controllo ritenuto legittimo, ma anche di un contrattacco travestito con forme di “accoglienza del nemico”, individuato come unica possibile tattica di arginamento dell’indubbio danno economico che il nuovo scenario ha imposto all’industria dei media.
E proprio sull’aspetto di “sostenibilità economica” del nuovo scenario culturale, oltre che su un’appassionata difesa di valori, consuetudini e certezze, è incentrato il più famoso dei saggi fuori dal coro. Si tratta di “The Cult of Amateur”, pubblicato nel 2007 da Andrew Keen, critico e giornalista statunitense. Keen, divenuto da subito bersaglio dei tecno-ottimisti di tutto il mondo, accusato da più parti di schierarsi a favore di un establishment vecchio e corrotto, e di non comprendere le potenzialità culturali della “partecipazione”, ha scritto invece un libro che, pur nelle inevitabili generalizzazioni e pur inciampando in qualche luogo comune, rappresenta il necessario controcanto a un dibattito che rischierebbe altrimenti di risolversi in una contrapposizione sterile. Tra una parte impegnata a difendere privilegi economici e quindi povera di motivazioni che vadano aldilà della tutela di un interesse, e una parte vitale e ottimista ma che a tratti si dimostra accecata dal proprio stesso entusiasmo.
Il critico americano, che si presenta come un “pentito” della tecnofilia Anni Novanta, stigmatizza con innegabile accuratezza e non senza ironia una certa cultura digitale, quella fatta di buzzword , di narcisismo digitale (“Everybody was simultaneously broadcasting themselves but nobody was listening”), di riciclo noncurante e incontrollato dell’informazione, di fiducia quasi religiosa nell’infallibilità dei motori di ricerca, di deresponsabilizzazione dell’atto della comunicazione. Senza poi mancare di elencare scientificamente i danni economici e sociali di quella che chiama “la cultura 2.0” (la perdita di posti di lavoro, la chiusura di molte realtà culturali medie e piccole, la difficoltà di sostentamento economico per autori e musicisti nell’era del peer-to-peer, la svalutazione della formazione). La metafora che ricorre nel libro, mutuata da T.H. Huxley (biologo evoluzionista padre del più noto Aldous), è il “teorema delle scimmie infinite”. Il teorema dice in sostanza che se dovessimo fornire a un numero infinito di scimmie un numero infinito di macchine da scrivere, ‘quasi’ sicuramente alcune di queste scimmie produrrebbero dei capolavori letterari, come un’opera di Shakespeare, o un Dialogo platonico. La provocazione è sin troppo chiara, e proprio in queste forzature retoriche sta il limite di questo saggio, che rimane tuttavia una lettura utile e rinfrescante.
Le difficoltà di adattamento al nuovo panorama sono evidenti, alcuni le guardano solo da lontano, molti di noi le sperimentano sulla propria pelle ogni giorno, nel bene e nel male. Ciò che è difficile negare, e che ci impedisce di abbracciare il “teorema della scimmie infinite”, è la coscienza dell’ascesa di quella che Chris Anderson , direttore di Wired USA e autore di “The Long Tail”, saggio sulle nuove economie dell’era digitale, più citato che letto, ha chiamato “cultura massicciamente parallela”: “Le stesse forze e le stesse tecnologie della coda lunga che stanno portando a un’esplosione di varietà e scelta per quanto riguarda il contenuto che consumiamo, tendono a trascinarci in vortici tribali. Quando la cultura di massa si disintegra, non si riforma in una massa diversa, si trasforma invece in milioni di micro-culture, che coesistono e interagiscono in uno sconcertante numero di modi.”
Valentina Tanni / 2008
[source: Digicult.it]